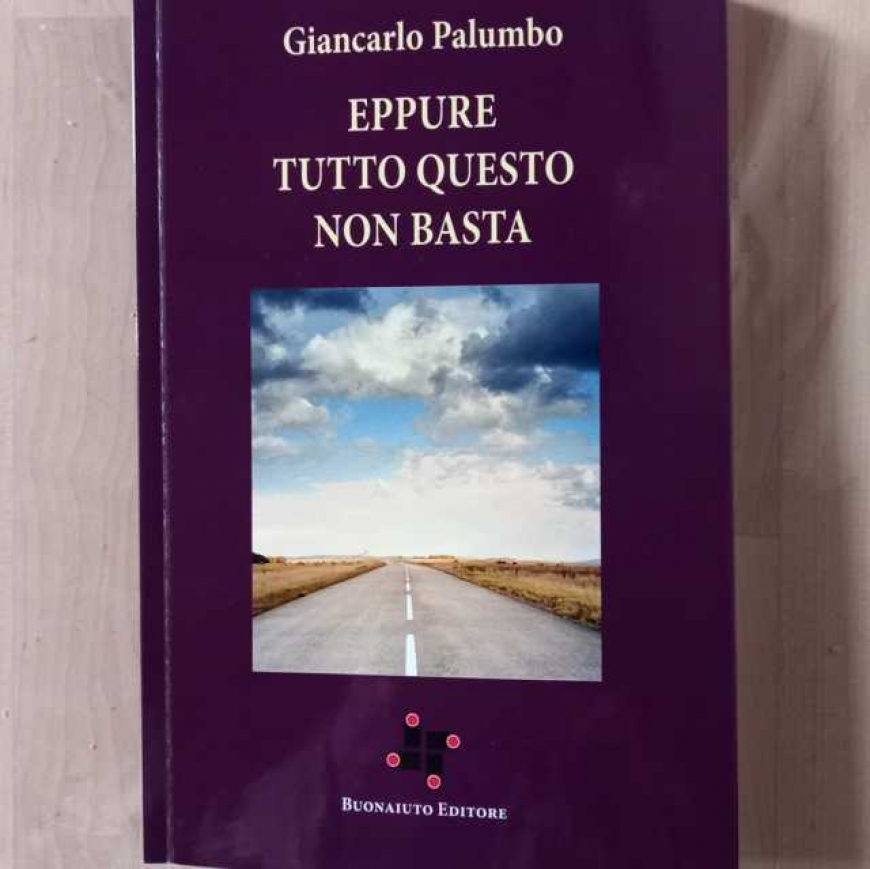Nota di lettura
Afferma l’autore che questa raccolta di scritti è il risultato della produzione “nel corso di una vita” (15). Si tratta dell’opera prima in una vita certamente non impegnata a scrivere libri, ma anche trascorsa a scrivere, come attestano la serie di lavori di cui è composto il libro e la mia stessa esperienza. Infatti Giancarlo Palumbo è un mio amico direi “antico” nel senso che ci si conosce ormai fa quasi mezzo secolo, con momenti in cui si si è perduti di vista e ci si è ritrovati, come ora.
Il tessuto del libro è composto e intrecciato di argomenti molti diversi, basta guardare non tanto l’indice – che, perché forse enunciato in modo estremamente generale, e non offre sùbito l’idea della complessità degli interessi che hanno animato una vita – ma gli argomenti effettivi delle sezioni, articolo per articolo.
Un particolare che colpisce il lettore è la quantità e la qualità delle citazioni e dei riferimenti ad autori illustri di tutti i tempi, dal teatro greco alla contemporaneità. Palumbo è un uomo eccezionalmente colto, che tra l’altro ha fortuna e merito d’una lunga esperienza matrimoniale con una compagna a sua volta amante dell libro e della lettura nonché della discussione.
Un momento forte che traspare in modo chiaro è l’impegno civile, prima a Vietri sul mare, città di nascita e della prima formazione, ma anche luogo di incubazione di questo atteggiamento: quegli anni vengono rievocati nelle pagine “Per padre Raffaele” (137 sgg.) che fu un uomo e un prete d’eccezione, oltre che una guida per tanti giovani. Poi a Sarno, il paese dove l’autore ha scelto di vivere, e di tale impegno vivono le pagine di Camminare per la città, in particolare quelle sull’antica scuola “De Amicis”, anche commentando o presentando le opere dell’amico Di Domenico, ma senza tralasciare il dialogo con gli autori come Calvino e gli altri. come quelle che riguardano la professione di insegnante della scuola primaria, condivisa anch’essa con la moglie. Un insegnante che va fiero di essere stato tale, come lo fu la vecchia guarda e anche è quella un po’ meno vecchia; che ha affiancato all’impegno con i bambini quello da “counselor”, quello dell’attività culturale sul territorio per la presentazione di libri di amici e altre iniziative, dando una mano anche all’Università di Salerno. Di tutto questo multiforme impegno speso il libro testimonia.
Ovviamente ho delle predilezioni, sebbene comprenda bene il tutto e ne ricavi una sensazione di struttura pensata e ben omogenea, di un libro che si tiene nelle sue parti componenti.
La prefazione, per esempio, perché si pone la domanda d’obbligo circa l’etica dello scrivere e vi risponde in modo convincente, a mio avviso. L’evocazione della figura umana e di docente di Mario Perniola, negli anni in cui fu a Salerno, dunque del contatto con lui.
L’autore è un esperto del cinema, e questo viene documentato in modo dettagliato, ma anche attraverso una scrittura piena di momenti godibili per chi legge, ad esempio allorché si tratta della questione del rapporto tra il reale e l’immaginario, per come viene vista nel cinema da certi autori (pp. 26 sgg.), in particolare da Edgar Morin.
La parte intitolata non si accettano cambi, invece, riguarda le concezioni etiche e antropologiche dell’autore: a mio parere egli si situa qui in una posizione idealmente comprensibile ma, di fatto, scarsamente difendibile sul lato fattuale, nel momento in cui si tratta di pensare la situazione del dono (chi di noi non si è trovato alle prese con le questioni obbligate cosa preferisco che mi si regali in questa occasione, oppure cosa regalo in quest’altra occasione?). La propensione che semberebbe prevalere oggigiorno sarebbe quella di eliminare problemi, regalando direttamente denaro in busta; ma si sarà già compreso che l’autore è nettamente contrario e, comunque la si pensi, si comprende che è una posizione argomentata la sua, e rispettabile.
Le lettere che aprono la seconda parte (forse si sarebbe potuto includere la risposta? Ma forse ragioni pratiche hanno dissuaso, o forse l'interlocutore non è più in vita e la risposta non poteva esservi) danno l’idea di un abito di socievolezza che chiunque lo conosca gli riconosce e che non s’è mai attenuata.
Avendo seguito in più occasioni the red box blog online, ritengo che gli scritti riportati alla fine del libro da quel sito e creati su svariati argomenti esprimano bene una posizione che viene maturando nel tempo, smussando gli spigoli e acquistando molto in opportune formulazioni di buon senso. Dunque questa parte mi sembra eccellente, nel ventaglio che si dispiega dal covid e conseguente black-out all’A.I. a questioni di etica, di sociologia, di antropologia, di psicologia sociale…
Una di queste discussioni riguarda il tema dell’amicizia. Sull’amicizia e dell’essere amici potrei dire, per mia esperienza di vita, che non vi sono, forse, due maniere di sentire identiche, e neppure necessita scavare tanto. Illustri posizioni vengono citate: da Confucio ad Aristotele a Derrida, da Dante a Montaigne. Si tratta non solo di leggere ma anche di sentirsi guidati a pensare: come si può dire per l’intero libro.